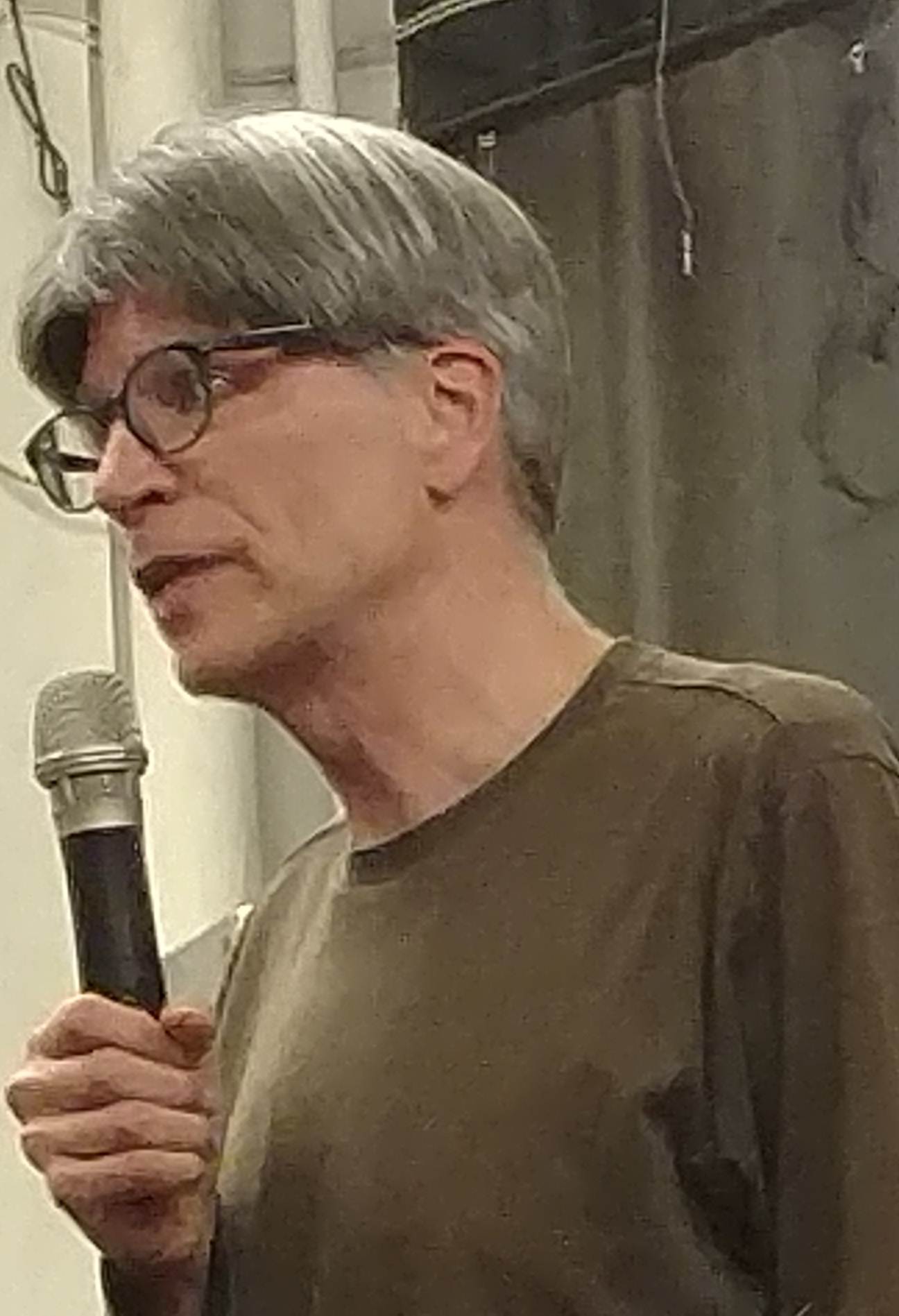Némirosky, Irène (2005). Suite francese (Suite française. trad. di Laura Frausin Guarino). Milano: Adelphi. ISBN: 9788845972577. Pagine 415. 6,99 €.

Solitamente diffido dei casi letterari. Quando sono pubblicati, li accompagnano commenti entusiastici: “Un capolavoro che si credeva perduto … a lungo ingiustamente dimenticato … che ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere la Francia | il romanzo di viaggio | la memorialistica | il romanzo di formazione”. Fate voi. Adelphi, poi è particolarmente versato in questa tecnica di marketing, che consiste nella capacità di montare a neve perfettamente gli albumi dell’ultimo volume edito. Ho sospettato per anni che Adelphi avesse un’intera squadra di redattori intenti a scrivere un ultimo romanzo di Joseph Roth (che, morto nel 1939, non poteva soddisfare la sete di bestseller dell’editore, al di là dei 17 romanzi pubblicati in vita) o, in via subordinata, di qualche altro oscuro scrittore della finis Austriae.
Se non ricordo male, Suite francese uscì in italiano verso fine del 2005. Mi sembra di ricordare che sotto le feste natalizie facesse bella mostra di sé in pile ordinate e odorose sul bancone dell’indimenticata libreria di Milano Libri in via Verdi, e di aver esitato se comprarlo per me o per regalarlo. Vinse la diffidenza.
Che cosa è cambiato ora, per farmelo leggere? Una specie di tormentone in Fedeltà di Marco Missiroli (che ho recensito qui): Suite francese è il libro che sta leggendo Margherita, una delle protagoniste, e i pochi accenni che Missiroli fa sono bastati a farmi venire voglia di leggerlo. Fedeltà, dunque, almeno qualche merito ce l’ha.
Per contro, l’essere citato in un altro libro (che peraltro ne cita molti, e non tutti a proposito) non è in sé un merito. Né, in sé, è un merito neppure l’essere nato in circostanze tragiche: Suite francese è l’insieme – la suite appunto, nell’accezione musicale del termine – dei primi due movimenti di un romanzo in cinque parti che Irène Némirosky stava febbrilmente scrivendo prima di essere arrestata e deportata ad Auschwitz, dove è stata uccisa all’arrivo. Merita, dunque, Suite francese?
Sì, è la mia risposta. Scritto in modo molto tradizionale (per quanto mi consente di giudicare la bella traduzione italiana), con un uso magistrale del discorso indiretto attraverso cui passa lo stream of consciousness dei protagonisti, molto “francese” nella sua delicatezza ma senza quell’ipertrofia dei periodi che caratterizza molti scrittori francesi, racconta con tenerezza e ferocia il primo anno della Seconda guerra mondiale in Francia, grosso modo dal giugno del 1940 al giugno del 1941.
Il tema è la reazione dei francesi all’invasione prima e all’occupazione tedesca poi. Ma – anche se Irène Némirosky ha una tesi – questa tesi non viene mai enunciata espressamente nel romanzo, ma solo nelle note di diario riportate in appendice al volume:
Da qualche anno tutto quello che si fa in Francia nell’ambito di una certa classe sociale ha un solo movente: la paura. È stata la paura a provocare la guerra, la sconfitta e la pace attuale. Il francese di questa casta non odia nessuno; non nutre gelosia né ambizione delusa, né un vero desiderio di vendetta. Ha una fifa blu. Chi gli farà meno male (non nel futuro, non in senso astratto, ma subito e sotto forma di ceffoni e calci nel sedere)? I tedeschi? Gli inglesi? I russi? I tedeschi lo hanno sconfitto, ma la punizione è presto dimenticata e i tedeschi possono difenderlo. Per questo lui è «per i tedeschi». A scuola, l’allievo più debole preferisce l’oppressione di un solo individuo all’indipendenza; il tiranno lo tartassa ma impedisce agli altri di rubargli le biglie, di picchiarlo. Se sfugge al tiranno, si ritrova solo, piantato in asso in mezzo alla mischia. (pos. 6017)
Piuttosto, viene fatta emergere dai pensieri e dalle azioni dei personaggi (è un romanzo corale) di cui narra le vicende. Nel primo romanzo, Temporale di giugno, lo sfondo è rappresentato dall’esodo di massa da Parigi dopo il primo bombardamento della città, nell’attesa dell’arrivo delle truppe tedesche, e fino alla notizia dell’armistizio. Ma l’autrice non dipinge tanto le scene di massa (anche se a tratti lo fa), ma segue le peripezie di alcune famiglie e personaggi: i Péricand (borghesi ricchi, potenti e cattolici tradizionalisti), i Michaud (piccolo-borghesi, ingenui e “sfigati”), il cinico banchiere Corbin, lo scrittore affermato e dannunziano Gabriel Corte (con amante al seguito), l’esteta collezionista Langelet. I personaggi si incontrano e si incrociano. Lo faranno anche nel romanzo successivo, sullo sfondo; e dagli appunti lasciati da Irène Némirosky si comprende che avrebbero continuato a farlo anche nei tre romanzi mancanti: in questo modo si inaugura una tecnica che ci è diventata familiare nelle serie televisive, e che in letteratura costituisce una caratteristica della narrativa di David Mitchell (qui ho recensito Cloud Atlas – qui avevo parlato del film che ne è stato tratto – e qui The Thousand Autumns of Jacob de Zoet). In questo modo si va componendo un grande affresco: in tutti la guerra fa emergere il peggio (per lo più, ma a volte anche il meglio), ma non li cambia radicalmente. Li estremizza, per così dire. Anche se vengono in mente alcuni scrittori e alcuni film italiani – in questo momento sto pensando a Una notte del ’43 (una delle Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani) e a La lunga notte del ’43, il bel film dell’esordiente Florestano Vancini (di entrambi ho parlato di sfuggita qui) – l’operazione di Irène Némirosky è di respiro ben più ampio.
Il secondo romanzo, Dolce, si muove su un registro più intimo: siamo in campagna, in un villaggio in cui si acquartierano i tedeschi. E nasce una delicatissima storia di amore tra una giovane signora francese (spostata per convenienza a un fedifrago che non ama, e che ora è prigioniero di guerra) e un ufficiale tedesco con la vocazione della musica. Un amore che proprio per il pudore dei protagonisti (non viene mai consumato, ma “il dono dell’anima […] precede quello del corpo”) ci appare ancora più tragico e impossibile, rivelatore dell’immane violenza che la guerra impone a tutti. Al di sotto le tensioni e le meschinità della provincia francese continuano ad emergere, tra acquiescenze collaborazionistiche, mercato nero e violenza rattenuta. Si accumulano nubi nere, ma il temporale non scoppia. Non ancora. La guarnigione tedesca parte per la Russia.
***
Le consuete citazioni, che fanno riferimento alle posizioni Kindle:
La carità cristiana, la mitezza di secoli di civiltà le cadevano di dosso come vani orpelli rivelando un’anima arida e nuda. Lei e i suoi figli erano soli in un mondo ostile. Doveva nutrire e proteggere i suoi piccoli. Il resto non contava più. (pos. 885)
Purché tutta quella confusione si placasse al più presto! Che si stabilisse un modo di vivere, uno qualsiasi, giacché tutto quel pandemonio, quella guerra, quelle rivoluzioni, quei grandi rivolgimenti della storia potevano esaltare gli uomini, ma le donne… Ah, le donne ne provavano solo fastidio! (pos. 1639)
Come sempre quando lui non la contraddiceva e si dichiarava pienamente d’accordo con lei, Jeanne cambiò subito parere. (pos. 2815)
Gli eventi gravi, fasti o nefasti che siano, non cambiano la natura di un uomo ma permettono di definirla meglio […] (pos. 3007)
Un’esistenza basata su angosce mortali è sopportabile solo a condizione di vivere alla giornata e dirsi, quando scende la sera: «Altre ventiquattr’ore in cui non è successo niente di particolarmente brutto, grazie a Dio! Aspettiamo domani». Tutti coloro che stavano intorno a Jean-Marie la pensavano così o quanto meno agivano come se pensassero così. Si occupavano delle bestie, del fieno, del burro, e non parlavano mai dell’indomani. Guardavano agli anni futuri, piantavano alberi che avrebbero dato i loro frutti a distanza di cinque o sei stagioni; ingrassavano il maiale che avrebbero mangiato di lì a due anni, ma non si soffermavano sull’immediato futuro. (pos. 3181)
E proprio mentre pensava così, il suo cuore, che era meno ragionevole di lei, cominciava a battere con tale violenza da soffocare tutti i rumori esterni, tanto che non sentiva più la voce di Benoît, gli strilli del bambino, il vento sotto la porta, e il tumulto del suo sangue la assordava come quando ci si tuffa sotto un’onda. (pos. 3712)
[…] «proibizione» non significava «impossibilità di superare l’ostacolo», semplicemente «difficoltà nel farlo»; una questione di tatto, di fortuna e di mezzi finanziari. (pos. 4318)
[…] poco interessato alle donne in generale e alla propria moglie in particolare. (pos. 4353)
[…] i pregiudizi sopravvivono alle passioni […] (pos. 4931)
[…] la buona educazione serve appunto a correggere le reazioni istintive della natura umana. (pos. 4937)
Dopo tutto, si giudicano gli altri solo in base al proprio cuore […] (pos. 4958)
Quello che divide o unisce gli individui non è la lingua, non sono le leggi, i costumi, i princìpi, ma il modo di tenere le posate! (pos. 5156)
[…] quell’urgenza di svelare il proprio cuore all’altro… un’urgenza da amante che è già un dono, il primo, il dono dell’anima che precede quello del corpo. (pos. 5295)
Tutto era meglio della musica, perché solo la musica abolisce le differenze di lingua o di abitudini fra due esseri e tocca fibre sensibilissime. (pos. 5461)